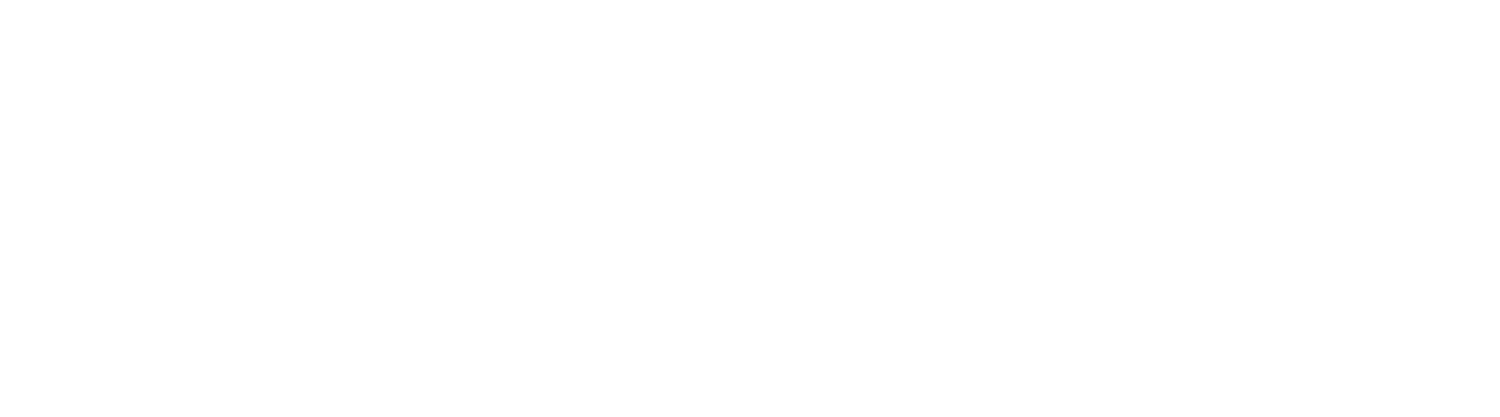Indice
La condotta penalmente rilevante: la rapina propria
La rapina impropria
L’elemento soggettivo: il dolo specifico
Il momento consumativo: il tentativo di rapina propria e impropria
La rapina aggravata
Il fatto di lieve entità: la decisione della Consulta
La differenza tra la rapina, l’estorsione ed il furto
Il delitto di rapina, reato contro il patrimonio, trova la sua disciplina nell’art. 628 c.p.. Si tratta di un tipico esempio di reato complesso ex art. 84 c.p.. Le condotte punibili infatti, in assenza di tale fattispecie sarebbero riconducibili ad un concorso tra i reati di furto (art. 624 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e violenza privata (art. 610 c.p.).
Nello specifico, l’art. 628 c.p. prevede due forme di rapina, la rapina propria e impropria, nonché ipotesi aggravate della stessa.
“Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità.
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d’incapacità di volere o di agire;
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416 bis;
3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;
3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.
Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.”
L’art. 628 c.p. è inoltre un tipico esempio di reato plurioffensivo. Nonostante lo stesso sia stato collocato dal legislatore nel XIII titolo del II libro del Codice Penale, ossia nel titolo dedicato ai reati contro il patrimonio, oltre al patrimonio, la fattispecie mira certamente a tutelare la sicurezza e la libertà individuale della persona che ne è vittima.
LA CONDOTTA PENALMENTE RILEVANTE: LA RAPINA PROPRIA
Si ha rapina propria (I comma) quando il soggetto agente sottrae la cosa mobile altrui e se ne impossessa attraverso l’uso della violenza rivolta verso la persona o della minaccia.
Il requisito della violenza e della minaccia previsto dalla norma fa si che la fattispecie si possa definire a forma vincolata, in quanto non ogni tipo di condotta di impossessamento della cosa mobile altrui potrà integrare il delitto ma solo quella che sia stata posta in essere in maniera violenta o minatoria.
In particolare la Suprema Corte ha definito il concetto di violenza e ne ha stabilito i confini. Secondo gli Ermellini “esso ricomprende infatti qualsiasi atto o fatto posto in essere dall’agente che si risolva comunque nella coartazione della libertà fisica o psichica del soggetto passivo che viene così indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare o omettere qualche cosa indipendentemente dall’esercizio su di lui di un vero e proprio costringimento fisico.” (Cass. Pen., Sez. II, 11 ottobre 2012, n. 1176)
Pertanto la violenza richiesta dal delitto di rapina è quella, fisica o psichica, in grado di annullare totalmente la sfera di libertà del soggetto passivo.
Per quanto riguarda invece l’altra modalità della condotta prevista dalla norma, ossia la minaccia, la stessa si individua nella seria prospettazione di un male ingiusto il cui verificarsi dipende dal soggetto agente. La minaccia deve inoltre avere ad oggetto la lesione o la messa in pericolo di beni giuridici di pertinenza della persona offesa. Può essere rivolta sia alla vittima che a soggetti diversi, purché abbia un vero e proprio effetto coercitivo sul possessore del bene che il rapinatore vuole ottenere. Un tipo di minaccia può rinvenirsi anche nell’aggressione violenta rivolta ad oggetti, quando tale azione è idonea ad ingenerare nella persona che assiste il timore che l’atto violento possa poi indirizzarsi verso di lei.
Il momento consumativo della rapina propria coincide con l’avvenuto impossessamento della res da parte del soggetto agente. Per impossessamento, come nel delitto di furto ex art. 624 c.p., si intende l’acquisizione dell’autonoma disponibilità del bene, ossia la possibilità di servirsene uti dominus poiché la res è uscita definitivamente dalla sfera di vigilanza del legittimo detentore.
LA RAPINA IMPROPRIA
La rapina impropria è invece prevista dal II comma dell’art. 628 c.p. e si differenzia dalla rapina propria in ragione del momento cronologico in cui si colloca l’azione violenta o minatoria. Nella rapina propria, come abbiamo avuto modo di osservare supra, la violenza o la minaccia si collocano in un momento antecedente alla sottrazione e all’impossessamento della cosa. Nella rapina impropria, invece, l’azione violenta o minatoria viene posta in essere dopo la sottrazione ma prima dell’impossessamento al fine di assicurarsi quest’ultimo o l’impunità.
Sul punto era nato un contrasto giurisprudenziale dovuto all’interpretazione della locuzione “immediatamente dopo la sottrazione”. Il contrasto vedeva da una parte i sostenitori della tesi dell’immediatezza tra sottrazione e comportamento violento, dall’altra coloro che sostenevano la tesi della necessaria contestualità tra i due momenti. Questi ultimi ritenevano che laddove non vi fosse contestualità spazio-temporale tra la sottrazione ed il successivo comportamento violento si sarebbe configurato il concorso materiale tra i reati di furto e violenza privata. La giurisprudenza prevalente però, accoglie la prima tesi a discapito della seconda. Così per aversi rapina impropria deve essere ancora in atto l’azione dell’impossessamento, essendosi già esaurita quella della sottrazione anche in luogo diverso purché vi sia consequenzialità e il tutto si possa comunque percepire come un’azione complessivamente unitaria. (Cfr. Cass. Pen., Sez. II, 24 marzo 2015, n. 14925; Cass. Pen., Sez. II, 10 aprile 2020, n. 13381).
L’ELEMENTO SOGGETTIVO: IL DOLO SPECIFICO
Il dolo richiesto ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 628 c.p. è il dolo specifico. È necessario dunque che oltre alla coscienza e volontà dell’azione sia dimostrata anche la particolare pulsione teleologica della stessa. La norma richiede infatti che la condotta penalmente rilevante sia posta in essere “ per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto”.
Per profitto ingiusto si intende qualsiasi soddisfazione o godimento che il soggetto agente ritiene di ottenere, anche non nell’immediato, dall’azione delittuosa. L’ingiustizia del profitto deriva dal fatto che lo stesso non trova alcuna tutela nell’ordinamento giuridico.
Per quanto attiene invece alla rapina impropria, si parla di dolo doppiamente specifico richiesto dalla norma. Infatti l’elemento soggettivo si intende integrato quando sia dimostrato il dolo del furto (il fine di trarre un profitto ingiusto) che non è espressamente previsto ma implicitamente richiamato, e l’ulteriore coscienza e volontà di porre in essere l’azione criminale al fine di assicurare a se ad altri il possesso della cosa o l’impunità.
IL MOMENTO CONSUMATIVO: IL TENTATIVO DI RAPINA PROPRIA E IMPROPRIA
Il reato di rapina propria si consuma nel momento in cui avviene l’impossessamento della cosa oggetto dell’azione criminosa.
Il tentativo di rapina propria è pacificamente ammesso ogniqualvolta il soggetto agente non sia riuscito ad sottrarre la res.
La rapina impropria invece si consuma nel momento in cui avvenuta la sottrazione si usi la violenza o la minaccia per gli scopi indicati dall’art. 628 c.p..
Il tentativo di rapina impropria si configura pacificamente nel momento in cui il soggetto agente ha sottratto la cosa e immediatamente dopo abbia usato violenza o minaccia per assicurarsi il possesso o l’impunità ma non riesce nell’intento.
Per quanto riguarda, invece, l’ipotesi in cui il soggetto attivo non porti a compimento la sottrazione della res e comunque eserciti violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità, dopo un acceso dibattito le Sezioni Unite hanno stabilito la piena configurabilità del tentativo ex art. 56 c.p. anche in tale caso (Cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 19 aprile 2012, n. 34952).
LA RAPINA AGGRAVATA
Il terzo comma dell’art. 628 c.p. prevede una serie di circostanze aggravanti speciali ad effetto speciale.
La rapina si considera aggravata quando:
- è commessa con armi (devono essere effettivamente utilizzate o comunque esibite), travisati (il volto del soggetto agente deve essere difficilmente riconoscibile) e in più persone riunite ( almeno 2 persone nel luogo e nel momento della rapina);
- il soggetto passivo è stato posto nell’incapacità di volere o di agire, dove la prima si ha quando il soggetto è posto nella condizione di non riuscire a manifestare una volontà contraria all’azione criminosa e la seconda quando la persona offesa è materialmente impossibilitata ad agire secondo volontà;
- è commessa da un mafioso anche se lo stesso non si avvale della forza intimidatrice nascente dal vincolo associativo;
- è commessa all’interno del domicilio o dei mezzi di pubblico trasporto;
- è commessa nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire o abbia appena fruito di servizi di istituti di credito, uffici postali , sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;
- è commessa nei confronti di persona
Quando sussiste una sola di queste ipotesi la pena prevista va dai 6 ai 20 anni di reclusione. Nel caso in cui, invece, sussistano più ipotesi tra quelle elencate sopra, ai sensi del IV comma dell’art. 628 c.p. la pena prevista è quella della reclusione da 7 a 20 anni.
Inoltre, ai sensi dell’art. 628, co. 5, c.p., le circostanze aggravanti dell’appartenenza mafiosa, del domicilio, dei mezzi pubblici e degli istituti di credito non possono essere ritenute equivalenti o subvalenti rispetto alle circostanze attenuanti generiche eventualmente riconosciute, diverse da quella prevista dall’art. 98 c.p..
Occorre infine precisare che la rapina aggravata ex art. 628, co. 3, c.p. è reato ostativo ex art. 4 bis, co. 1 ter, l. n. 354/1975. Ciò significa che, ai sensi dell’art. 656, co. 9, c.p.p., in caso di condanna in via definitiva, l’ordine di esecuzione della pena non potrà essere sospeso. La conseguenza è che il condannato sarà tradotto direttamente in carcere. Lo stesso, però, potrà avere accesso ai benefici penitenziari solo laddove non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, in aggiunta, naturalmente, agli specifici requisiti necessari per la concessione di ciascun beneficio particolare.
IL FATTO DI LIEVE ENTITA’: LA DECISIONE DELLA CONSULTA
Come si evince agilmente dalla lettura della norma di cui all’art. 628 c.p., il legislatore non ha previsto una fattispecie di rapina attenuata laddove il fatto dovesse risultare particolarmente lieve.
Sul punto, di recente, ha sollevato questione di legittimità costituzionale il Tribunale di Cuneo in relazione all’art. 628, co. 2, c.p. per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. “nella parte in cui non prevede una diminuente quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.”
La tesi dell’illegittimità costituzionale della norma veniva motivata sostenendo che, con riferimento ad altri delitti parimenti gravi contenuti nel codice penale, il legislatore aveva previsto delle ipotesi attenuate quando il fatto fosse risultato di lieve entità. Ad avviso del rimettente risultava quindi irragionevole la mancata previsione di un’analoga ipotesi per il delitto di rapina impropria, nonché sproporzionato il trattamento sanzionatorio che si veniva così a delineare.
La Corte Costituzionale ha accolto la tesi del giudice a quo e, introducendo una c.d. valvola di sicurezza, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen. “nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità”, nonché “l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.”(Corte Cost., Sent. 13 maggio 2024, n. 86).
LA DIFFERENZA TRA LA RAPINA, L’ESTORSIONE E IL FURTO
Apparentemente il delitto di rapina può presentare alcune difficoltà interpretative nel rapporto con il diverso delitto di estorsione ex art. 629 c.p.. Tali difficoltà si rinvengono nella medesima caratterizzazione delle modalità della condotta richieste da entrambe le norme. Sia il delitto di rapina che quello di estorsione richiedono che l’azione sia commessa con violenza o minaccia. In realtà la differenza tra le due fattispecie si rinviene nel diverso grado di violenza o minaccia impiegato. Pertanto sussiste il reato di rapina quando la violenza o la minaccia sono tali da annullare completamente la volontà del soggetto passivo. Sussiste invece l’estorsione quando la violenza o la minaccia, seppur intense, lasciano un margine di autonomia d’azione alla persona offesa dal reato.
Altro rapporto problematico si rinviene tra la rapina e il furto, in particolare il furto con strappo. Abbiamo già avuto modo di osservare in precedenza come il delitto di rapina sia considerato un reato complesso, il quale al suo interno contiene tutti gli elementi tipici del furto. Si differenzia da quest’ultimo solo in relazione ad un requisito in più richiesto dalla fattispecie e non presente nel furto, ossia la violenza alla persona o la minaccia.
Se è particolarmente agevole distinguere il furto dalla rapina, un po’ meno lo è quando consideriamo il c.d. furto con strappo previsto dall’art. 624 bis, co. 2, c.p.. Sul punto la giurisprudenza afferma che “integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via indiretta contro la persona detentrice del bene, mentre ricorre il delitto di rapina quando la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché in tal caso è la violenza stessa – e non lo strappo – a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione” (Cass. Pen., Sez. II, sent. 5 dicembre 2013, n. 2553).