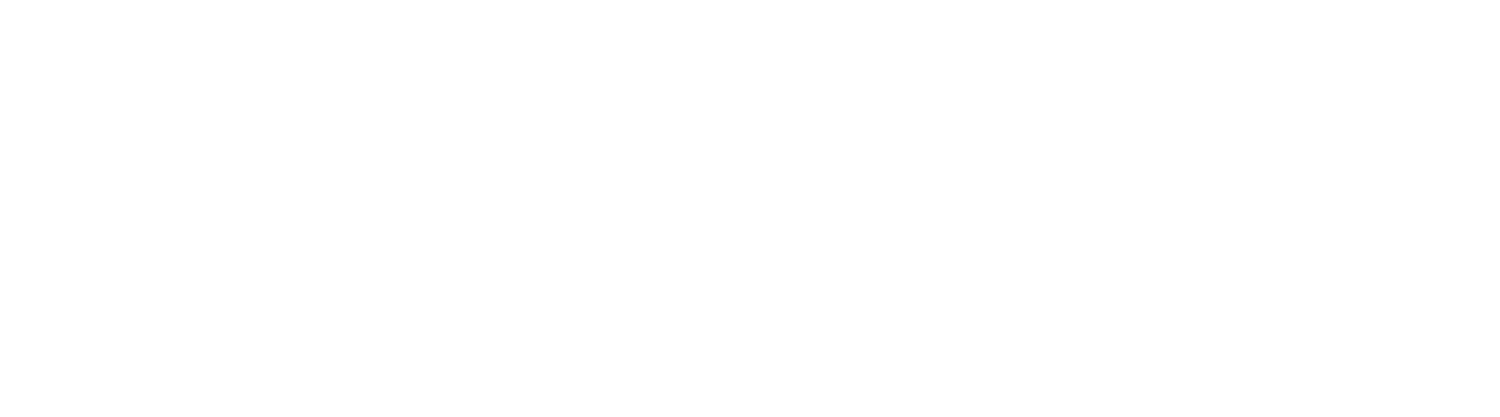Indice
La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato rappresenta un istituto giuridico di fondamentale importanza nel sistema penale italiano. Introdotto dalla legge n. 67 del 28 aprile 2014, questo strumento si pone come un’alternativa al processo penale tradizionale, mirando a favorire il recupero e la rieducazione del reo, valorizzando al contempo il principio di legalità e il diritto di difesa.
Il presente articolo si propone di analizzare in modo dettagliato la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova, esaminandone il contesto normativo, le finalità, le modalità di attuazione e gli effetti giuridici.
In particolare la messa alla prova è disciplinata dall’art. 168-bis del Codice Penale, il quale prevede che l’imputato, in presenza di determinate condizioni, possa richiedere di essere sottoposto a un programma di trattamento e recupero piuttosto che ad un procedimento penale tradizionale. La legge n. 67/2014 modifica il sistema precedente, introducendo la messa alla prova come strumento di deflazione non solo processuale ma anche, indirettamente, penitenziaria. La stessa si presenta anche come un istituto finalizzato a soddisfare le esigenze di ricomposizione tra autore e vittima del reato.
CHI PUO’ RICHIEDERLA?
Il procedimento di messa alla prova si articola in diverse fasi, a partire dalla richiesta dell’imputato di essere sottoposto a tale misura, fino alla verifica del suo comportamento al termine del percorso di recupero.
La richiesta deve essere presentata all’autorità giudiziaria entro un termine specifico dopo la contestazione del reato (nel corso delle indagini preliminari, nell’udienza preliminare o, nei procedimenti con citazione diretta a giudizio, nell’udienza predibattimentale), e deve essere accompagnata da una dettagliata proposta di programma di trattamento. La proposta può includere interventi sociali, educativi, terapeutici o lavorativi, mirati al reinserimento dell’imputato nella società.
Più in particolare la richiesta può essere avanzata dall’imputato o dal suo difensore munito di procura speciale, ovvero, novità introdotta dal d.lgs. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), anche dal Pubblico Ministero. Il giudice prima di procedere chiede il consenso del Pubblico Ministero e sente la persona offesa.
QUALI SONO I REQUISITI PER OTTENERLA?
Affinché l’imputato possa accedere a tale misura, è necessario che non si proceda per un reato per cui la legge preveda obbligatoriamente la pena detentiva superiore a un determinato limite. Inoltre, il soggetto deve essere consapevole della richiesta e deve dimostrare di voler intraprendere un percorso di rieducazione. La decisione di ammettere l’imputato alla messa alla prova spetta al giudice, il quale valuta anche la personalità dell’imputato e il suo comportamento.
Più in particolare, l’istituto suddetto può essere attivato a fronte della sussistenza dei seguenti requisiti:
-
-
- reati puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 4 anni;
- reati previsti dall’art. 550 co. 2 c.p.p. (es. furto pluriaggravato, ricettazione, falsa testimonianza, frode in assicurazione, omessa dichiarazione dei redditi etc…);
- non aver già beneficiato in precedenza della messa alla prova;
- idoneità del programma presentato dall’imputato (valutazione del giudice);
- prognosi di astensione dal commettere ulteriori reati (valutazione del giudice).
-
IN CHE COSA CONSISTE?
Una volta ricevuta la richiesta, il giudice valuta se vi siano i presupposti per accogliere la domanda. In questa fase, come abbiamo avuto modo di osservare in precedenza, non si tratta solo di verificare la sussistenza dei requisiti normativi, ma anche di esaminare il programma proposto, accertando che sia adeguato alle esigenze dell’imputato.
Se la richiesta viene accettata, il giudice emette un’ordinanza di sospensione del procedimento e dispone la messa alla prova. Il procedimento può essere sospeso a seconda dei casi per una durata variabile che non può comunque superare i due anni se si procede per reati puniti con pena detentiva o un anno se si procede per reati puniti con pena pecuniaria.
L’imputato, quindi, intraprende un percorso di recupero, sotto la supervisione di operatori sociali e, se necessario, di consulenti specifici (psicologi, educatori, etc.). Durante questo periodo, l’imputato svolge il lavoro di pubblica utilità secondo il programma di trattamento e le prescrizioni approvate dal giudice. Per il buon esito della prova è fondamentale che il soggetto segua le indicazioni del programma e partecipi attivamente ai trattamenti previsti.
Durante il periodo di messa alla prova, il procedimento penale è temporaneamente sospeso. Questo significa che non si svolgono attività processuali né si assumono decisioni in merito alla responsabilità penale dell’imputato. Tuttavia, la sospensione non implica l’estinzione del reato, ma solo una fase di attesa per valutare l’andamento del programma di trattamento.
Tale andamento viene valutato nel corso di udienze intermedie che vengono appositamente fissate dal giudice.
Nel caso in cui durante tali udienze il giudice accerti delle irregolarità, lo stesso è chiamato a revocare la sospensione del procedimento con conseguente ripresa del processo penale tradizionale.
Nel dettaglio ciò avviene nei seguenti casi (art. 168 quater c.p.):
-
-
- grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte;
- rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;
- commissione di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole di quello per cui si procede.
-
QUALI SONO GLI EFFETTI?
Uno degli aspetti più significativi della sospensione del procedimento con messa alla prova è rappresentato dagli effetti che essa produce sul procedimento penale stesso e sull’imputato.
Se l’imputato completa con successo il programma di recupero, il giudice dispone l’estinzione del reato. Questo rappresenta l’obiettivo principale della messa alla prova: fornire all’imputato l’opportunità di redimersi, senza subire le conseguenze di un procedimento penale. L’esito positivo può anche influire sulla vita sociale e lavorativa dell’imputato, favorendo il suo reinserimento nella comunità.
In tal caso, il procedimento penale conclusosi con esito positivo della messa alla prova non verrà iscritto nel casellario giudiziale rilasciato a richiesta dell’interessato, ma solo in quello rilasciato per fini di giustizia.
Tale conseguenza è di notevole importanza perché consente all’imputato di non subire alcuna conseguenza negativa derivante dallo stigma della c.d. “fedina penale sporca” e potendosi ad esempio presentare al mondo del lavoro completamente “pulito”.
Al contrario qualora l’imputato non rispetti le condizioni imposte dal programma di trattamento, il giudice, come già anticipato supra, può decidere di revocare la messa alla prova, riprendendo il procedimento penale. In questo caso, l’imputato dovrà affrontare le conseguenze legate al reato originario, con la possibilità di una condanna detentiva.
DIFFERENZA TRA MESSA ALLA PROVA PER MAGGIORENNI E PER MINORENNI
L’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova per maggiorenni differisce notevolmente da quello per minorenni previsto dall’art. 28 D.P.R. n. 448/1988.
In primo luogo e come affermato dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza del 20 febbraio 2019 n. 68, una fondamentale differenza tra i due istituti si rinviene nella ratio legis. Infatti, mentre la messa alla prova per maggiorenni ha tra l’altro una sicura connotazione sanzionatoria, in quella per minorenni invece manca totalmente ed anzi “il senso delle prescrizioni inerenti al programma cui l’imputato deve essere sottoposto appare esclusivamente orientato a stimolare un percorso rieducativo del minore.”
Quanto sostiene la Consulta trova conferma nella diversa circostanza per cui la messa alla prova per minorenni può essere concessa anche più volte per qualunque tipo di reato, senza che sia presente un limite massimo.
In realtà occorre precisare che l’art. 28, co. 5 bis D.P.R. 448/1988 esclude l’applicabilità di tale istituto nei casi di omicidio aggravato, violenza sessuale aggravata e rapina aggravata.
CONCLUSIONI
Nonostante i vantaggi della sospensione del procedimento con messa alla prova, esistono diverse criticità e problematiche legate all’applicazione pratica di questo istituto giuridico.
Una delle principali critiche mosse, riguarda la selettività dell’accesso alla messa alla prova. Poiché questo istituto è riservato a specifiche categorie di reati, si solleva il dubbio sulla sua effettiva equità. Inoltre, vi è preoccupazione riguardo alla definizione del programma di trattamento e alla sua efficacia nel garantire la rieducazione degli imputati.
Altra criticità riguarda le tempistiche. Basti pensare che per la sola elaborazione del programma di trattamento possono trascorrere molti mesi, a causa dell’enorme carico di lavoro di cui è investita la struttura deputata all’adempimento (U.E.P.E.). Ciò comporta un inevitabile allungamento della durata dei processi.
Ad ogni modo la messa alla prova può avere effetti notevolmente positivi sulla vita sociale e professionale dell’imputato. Il completamento con successo del programma di trattamento può aumentare le opportunità di lavoro e migliorare le relazioni interpersonali, contribuendo a una maggiore integrazione nella comunità. Inoltre, come detto in precedenza, l’assenza di una condanna penale consente di evitare discriminazioni nel mercato del lavoro.
Inoltre, fino a quando l’imputato non completa il programma o viene revocata la messa alla prova, permane la presunzione di non colpevolezza. Questo principio giuridico, che caratterizza il nostro sistema penale, è centrale per garantire i diritti fondamentali dell’individuo e preservare l’equità del processo.
In sintesi, la messa alla prova non solo offre all’imputato una possibilità concreta di riabilitazione e reinserimento sociale, ma produce anche effetti giuridici significativi legati alla sospensione del procedimento, all’estinzione del reato e alla gestione del comportamento dell’imputato durante il percorso di trattamento.