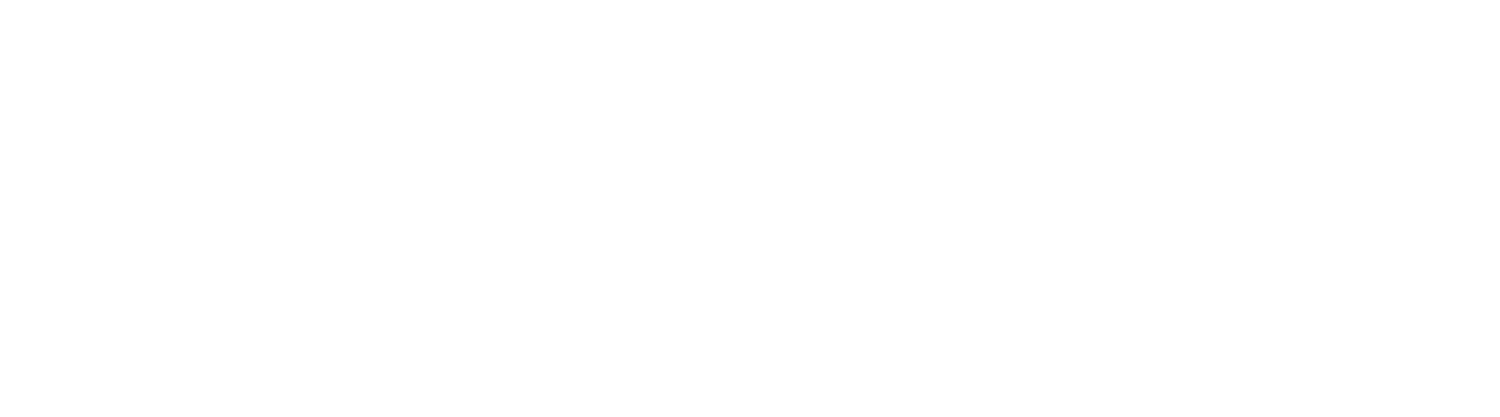Indice
Il Decreto Sicurezza 2025, più precisamente D.L. 11 aprile 2025 n. 48, convertito in legge il 4 giugno 2025, si presenta come una risposta alle sempre più pressanti istanze di sicurezza pubblica e di ordine sociale avanzate dai cittadini. In un contesto globale caratterizzato da sfide emergenti, quali il terrorismo, i flussi migratori incontrollati, e la crescente incidenza di eventi criminogeni, il legislatore italiano ha avvertito l’urgenza di adattare la propria risposta legislativa alle nuove realtà.
Il provvedimento si inserisce in un filone normativo già avviato con i precedenti decreti sicurezza, ma si distingue per la sua complessità e per l’ampia gamma di misure che intende adottare. Queste misure spaziano dalla riforma delle procedure di identificazione e di trattenimento dei migranti, fino all’inasprimento delle pene per reati specifici e all’introduzione di nuove fattispecie incriminatrici. L’approccio del decreto è incentrato non solo sulla repressione, ma anche sulla prevenzione, ponendo l’accento sulla necessità di una cooperazione interistituzionale e sul coinvolgimento attivo della comunità.
Tuttavia, l’introduzione di tali misure non è esente da critiche. Molti esperti e associazioni per i diritti umani sollevano preoccupazioni riguardo al potenziale di tali normative di compromettere diritti fondamentali, come il diritto alla privacy e il diritto di asilo. Inoltre, il dibattito politico attorno al decreto è acceso: da un lato, i sostenitori ne evidenziano la necessità nel rafforzamento della sicurezza nazionale; dall’altro, i critici avvertono dell’eventuale rischio di una deriva autoritaria.
In questo articolo, ci proponiamo di analizzare le principali disposizioni del Decreto Sicurezza 2025, valutandone le implicazioni giuridiche, concentrandoci primariamente sulle norme che intervengono in materia penalistica.
CONTRASTO AL TERRORISMO
In materia di contrasto al terrorismo il decreto introduce due nuove fattispecie di reato:
Art. 270 -quinquies .3 (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo) il quale si propone di punire con la pena della reclusione da 2 a 6 anni chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270 -bis e 270 -quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso di congegni bellici micidiali, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale.
La seconda nuova fattispecie di reato viene introdotta aggiungendo un secondo comma all’art. 435 c.p. rubricato Fabbricazione o detenzione di materiali esplodenti, il quale:
al primo comma punisce con la pena della reclusione da 1 a 5 anni “chiunque al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servono alla composizione o alla fabbricazione di esse.”
Il nuovo secondo comma prevede invece la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni per chiunque “Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo (i.e. delitti contro l’incolumità pubblica) puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.”
Come è agevole notare l’intervento legislativo mira a punire tanto le condotte di detenzione e procacciamento quanto quelle di diffusione e divulgazione di istruzioni o tecniche per la creazione di ordigni per il compimento di atti di terrorismo o comunque gravemente lesivi della pubblica incolumità.
SICUREZZA URBANA: OCCUPAZIONI ABUSIVE
Uno degli interventi più controversi e discussi del decreto è proprio quello previsto nel capo II in materia di sicurezza urbana.
Al fine di contrastare il diffuso fenomeno delle occupazioni abusive degli immobili, particolarmente sentito dall’opinione pubblica, il legislatore ha introdotto nel codice penale la seguente fattispecie di reato:
Art. 634- bis c.p. (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui).
“Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è unito con la reclusione da due a sette anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o aggiri ovvero cede ad altri l’immobile occupato.
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma.
Non è punibile l’occupante che collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Si procede d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.”
Dalla lettura del dettato normativo si evincono 3 diverse ipotesi di reato previste dai primi 3 commi (occupazione violenta, appropriazione truffaldina e intermediazione) e una causa di non punibilità prevista dal IV comma.
Inoltre il legislatore per snellire le procedure di rilascio dell’immobile arbitrariamente occupato e renderne effettiva la liberazione e il reintegro nel possesso del proprietario, ha introdotto una nuova misura cautelare prevista dall’ art. 321 -bis c.p.p. (Reintegrazione nel possesso dell’immobile), in virtù della quale, su richiesta del pubblico ministero, il giudice competente dispone con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell’immobile oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell’articolo 634 -bis del codice penale.
Nei casi in cui l’immobile occupato sia l’unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria, espletati i primi accertamenti volti a verificare la sussistenza dell’arbitrarietà dell’occupazione, si recano senza ritardo presso l’immobile del quale il denunziante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le attività di indagine.
Dopodiché laddove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, sempre gli ufficiali di polizia giudiziaria ordinano all’occupante l’immediato rilascio dell’immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso dell’immobile medesimo anche coattivamente.
Nelle quarantotto ore successive gli ufficiali di polizia giudiziaria trasmettono il verbale al pubblico ministero competente; questi, se non dispone la restituzione dell’immobile al destinatario dell’ordine di rilascio, richiede al giudice la convalida e l’emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale.
SICUREZZA URBANA: BLOCCO STRADALE
Una delle tecniche di manifestazione del dissenso utilizzate con una certa frequenza in tempi recenti da parte di alcuni cittadini e associazioni è stata quella della costituzione di blocchi stradali.
Secondo questa tecnica i manifestanti, senza preavvisare l’autorità di pubblica sicurezza, invadono la sede stradale (anche autostrade) attuando con la loro presenza fisica una forma non violenta di protesta consistente in un blocco del traffico veicolare.
Tale azione presenta molteplici fattori di rischio per l’incolumità pubblica, in particolar modo risulta pericolosa tanto per l’incolumità dei manifestanti quanto per la sicurezza stradale.
Per contrastare questo fenomeno il legislatore ha trasformato quello che prima era un illecito amministrativo in illecito penale.
Così l’art. 1 -bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, relativo all’impedimento della libera circolazione su strada prevede ora la pena della reclusione fino ad 1 mese o la multa fino a 300 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite la pena è della reclusione da 6 mesi a 2 anni.
IL REATO DI RIVOLTA NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI E NELLE STRUTTURE DI TRATTENIMENTO PER I MIGRANTI
Altra novità del decreto in oggetto è l’introduzione del delitto di rivolta all’interno di un istituto penitenziario ex art. 415 bis c.p.
La suddetta norma prevede la pena della reclusione da 1 a 5 anni per chiunque, all’interno di un istituto penitenziario, partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all’esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza, commessi da tre o più persone riunite.
Una importante novità della fattispecie è la criminalizzazione, prevista dal II comma, della resistenza passiva, ossia quella forma di opposizione all’azione dell’autorità non costituente una aggressione diretta o indiretta ai pubblici ufficiali bensì un mero rifiuto di collaborazione (es. puntare i piedi o farsi trascinare di peso).
Pene più severe sono previste per coloro che organizzano o dirigono la rivolta (2-8 anni di reclusione) o per coloro che vi partecipano con l’uso delle armi (fino a 10 anni di reclusione a seconda dei casi), nonché nei casi in cui dal fatto derivi una lesione personale grave o gravissima o la morte (fino a 20 anni di reclusione).
Da ultimo giova segnalare che tale delitto è stato altresì inserito nella lista dei reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari di cui all’art. 4 bis, co. 1 ter L. 26 luglio 1975 n. 354 (ordinamento penitenziario).
Analoga disposizione è stata introdotta nell’art. 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 7.1, con riferimento alle condotte rivoltose commesse dai migranti all’interno delle strutture adibite al trattenimento degli stessi.
MISURE A TUTELA DELLA FORZE DI POLIZIA
Al fine di approntare una maggior tutela alle Forze di polizia nell’espletamento delle funzioni di istituto, il legislatore ha previsto un aumento delle pene relativamente ai reati aggravati di resistenza (art. 337 c.p.), minaccia e violenza (art. 336 c.p.), nonchè lesioni (art. 583 quater c.p.) a pubblico ufficiale.
Inoltre sono stati stanziati circa 20 milioni di euro, ripartiti in 3 anni, per l’approntamento delle c.d. bodycam, ovverosia strumenti di ripresa audiovisiva indossabili che potranno essere dati in dotazione al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di mantenimento dell’ordine pubblico, di controllo del territorio e di vigilanza di siti sensibili nonché in ambito ferroviario e a bordo dei treni al fine di registrare lo svolgimento dell’attività operativa.